Non tutti i terreni sono uguali e, di conseguenza, ogni terreno richiede cure specifiche in termini di lavorazioni del suolo, e, in presenza di colture in atto, di irrigazione e fertirrigazione. Non solo: ad ogni tipo di terreno corrispondono specie e varietà vegetali più o meno adatte. Ecco perché prima di avviare una qualsiasi coltivazione è fondamentale conoscere la natura del terreno sul quale si intende lavorare.
Oltre ad analizzare le variabili di tipo chimico, come le caratteristiche dell’humus e il pH, bisogna individuare struttura e tessitura del terreno, perché hanno un effetto di tipo fisico e meccanico sulla coltivazione.
La fertilità fisica è la capacità del terreno di assorbire, trattenere e drenare l’acqua, ma anche di far circolare l’aria e di ospitare gli apparati radicali. Le condizioni strutturali del terreno e la composizione dei minerali incidono anche sulla capacità di trattenere i nutrienti, quindi sulla fertilità chimica, e devono essere in grado di garantire la vita agli organismi che contribuiscono alla fertilità biologica. Le caratteristiche fisiche del terreno hanno inoltre un impatto sulla lavorabilità e sulla resistenza all’erosione.
La tessitura
Da un punto di vista fisico, il terreno agrario è una sorta di miscela di particelle minerali: sono proprio le diverse percentuali di queste particelle che distinguono un terreno dall’altro.
Le particelle che superano i 2 mm di diametro rappresentano lo scheletro e sono generalmente di ostacolo alla coltivazione. Si tratta infatti di ciottoli e ghiaia che dovrebbero essere presenti in minima parte.
Le particelle con un diametro inferiore ai 2 mm compongono la cosiddetta “terra fine”, e sono di tipo sabbioso, argilloso o limoso. A loro volta, sabbia, argilla e limo si presentano con diverse granulometrie, che incidono sul comportamento fisico e meccanico del terreno. La tessitura del terreno corrisponde alla quantità e alle dimensioni di questi tre elementi minerali.
Sabbia
La sabbia si presenta in particelle che vanno da poche decine di micron a quasi 2 mm e presenta quindi una grande variabilità, dalla molto fine alla molto grossa. La sabbia è estremamente permeabile, quindi non trattiene l’acqua e i nutrienti che essa trasporta. La sua presenza, nelle giuste quantità, evita il ristagno dell’acqua, e inoltre migliora la lavorabilità del terreno, mentre in quantità eccessive lo impoverisce.
Argilla
Le particelle di argilla sono le più piccole tra le componenti minerali, e hanno diametri inferiori ai 2 micron. Vantaggi e svantaggi sono di tipo opposto rispetto alla sabbia. L’argilla infatti non è permeabile, ma colloidale e non solubile, con tendenza a cementificare: di conseguenza, se non è ben bilanciata provoca ristagno dell’acqua. La sua presenza nel terreno è indispensabile per trattenere acqua e sali minerali in quantità sufficienti a nutrire le piante.
Limo
Il limo rappresenta una via di mezzo tra sabbia e argilla, a seconda delle dimensioni dei granuli. Le particelle più grandi si comportano come la sabbia, mentre le più piccole tendono a compattare il terreno e generano ristagno.
A ogni pianta il suo terreno
Un terreno “ideale” è quello a medio impasto, cioè con un equilibrato bilanciamento delle componenti minerali. Abbiamo messo la parole “ideale” tra virgolette perché, in realtà, molto dipende dal tipo di coltura. Per fare qualche esempio, le patate hanno bisogno di un terreno franco sabbioso, mentre il riso richiede terreni con poca capacità drenante e quindi con una maggiore concentrazione di argilla e limo.
Una pratica guida alla classificazione delle tessiture è il diagramma elaborato dall’USDA (il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti).
Tipologie di analisi del terreno
Prima di impiantare una coltura è consigliabile procedere a un’analisi della tipologia del suolo per verificare l’utilità di eventuali correttivi, ad esempio per correggere l’alcalinità o la salinità.
Le tipologie di analisi sono:
- Fisiche: forniscono informazioni sulla granulometria di un suolo
- Chimiche: macroelementi, microelementi, conducibilità elettrica ecc.
- Chimiche e fisiche: tessitura e caratteristiche chimiche
Le analisi chimico-fisiche permettono di sapere se un suolo è calcareo o acido, parametri fondamentali che influiscono non poco sulle salute delle piante. Un terreno limoso, per esempio, potrebbe presentare un elevato contenuto di carbonato di calcio. Una dotazione eccessiva di calcare provoca inconvenienti come l’insolubilizzazione del fosforo e del ferro (responsabile della classica clorosi ferrica degli agrumi, della vite americana ecc.), la creazione di crosta e la formazione di fangosità in presenza di acqua. Il calcare inoltre può influire sul pH (subalcalino o moderatamente alcalino).
I più esperti e dotati di competenze tecniche possono riconoscere, visivamente, la tessitura e ipotizzare il “contenuto” delle sostanze nutritive e S.O. (sostanza organica), ma in questo caso bisognerebbe anche conoscere la storia di quell’appezzamento: quali colture ha ospitato questo suolo? Colture depauperanti? Colture migliorative?
Per queste ragioni consigliamo di non soffermarsi mai ad una semplice analisi visiva. L’analisi di laboratorio è sicuramente più affidabile.
Come procedere all’analisi
Per eseguire un’analisi del suolo occorre prelevare un certo quantitativo di terra e portarlo in un laboratorio specializzato. Su richiesta, il laboratorio può inviare un tecnico che sa come prelevare un campione utile, o più campioni in punti diversi.
L’analisi chimico-fisica completa ha generalmente un costo variabile tra gli 80 e i 150 euro, ai quali vanno aggiunti gli eventuali costi di trasferta per il tecnico.
Se vuoi eseguire un’analisi del tuo terreno, contattaci e ti daremo tutte le informazioni sui laboratori che abbiamo selezionato per questo servizio.
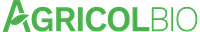

























Rispondi Elimina commento